Evoluzione del debito pubblico
Negli ultimi anni la tematica del debito pubblico italiano è al centro di discussioni e dibattiti in tutti gli ambiti politico-istituzionali e sulla stampa. Senza voler entrare nel merito delle possibili soluzioni per l’abbattimento dello stesso (vendita del patrimonio pubblico, imposta straordinaria sui grandi patrimoni, riforma delle pensioni, sottoscrizione forzosa di titoli del debito pubblico, etc.) si vuole, in questa sede, spiegare le categorie fondamentali e la dinamica della finanza pubblica.
Il debito pubblico è un concetto di stock e rappresenta la somma dei vari disavanzi accumulati negli anni dallo Stato.
Invece il disavanzo pubblico o deficit dello Stato è un avanzo negativo, cioè un eccesso delle uscite sulle entrate in un determinato anno. Per semplicità indicando con T le entrate, con G la spesa pubblica per beni e servizi e con TR i trasferimenti (cioè i passaggi di denaro dallo Stato ai cittadini), avremo che la condizione di pareggio di bilancio si ha quando le entrate sono uguali alle uscite, e cioè quando viene rispettata la seguente eguaglianza: G + TR = T. E’ evidente che uno squilibrio si crea allorché non venga rispettata la predetta eguaglianza.
Il disavanzo primario (o saldo primario negativo) è il disavanzo totale al netto della spesa per interessi. Infatti il disavanzo pubblico normalmente è finanziato con emissione di titoli di stato e la spesa per la remunerazione degli interessi genera altro debito. Concentrarsi sul saldo primario (positivo o negativo) significa analizzare più propriamente le scelte del governo in carica in quanto non viene considerata la spesa per interessi. Questo indicatore, dunque, è un una grandezza utile per giudicare i risultati della politica di bilancio, ovvero i meriti ed i demeriti, dei governanti in un dato periodo.
Con il Trattato di Maastrich del 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993, è stato stabilito che le economie dei Paesi firmatari siano rese sufficientemente omogenee, valutate sulla base di un complesso di parametri, chiamati tecnicamente criteri di convergenza. Gli obiettivi prefissati nel trattato rappresentano, dunque, un percorso forzato per ogni Paese dell’Unione Europea, il quale è obbligato a completare o avviare un ineludibile processo di risanamento dei conti pubblici per rientrare nei criteri di convergenza. Tra i parametri in grado di valutare lo stato di salute di una economia nazionale i più significativi sono due:
1. il rapporto tra deficit di bilancio pubblico e il prodotto interno lordo (PIL), che non deve superare il 3%;
2. il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL), che non deve essere superiore al 60%. Questo parametro è derogabile, nel senso che è importante l’andamento tendenziale sulla via del risanamento1.
Detto ciò, gli elementi che determinano la dinamica del rapporto tra debito pubblico/PIL sono il saldo primario positivo/negativo, la spesa per interessi e la crescita economica.
Nel momento in cui uno Stato spende velocemente, con il prelievo fiscale che cresce lentamente, se i conti pubblici prima del pagamento degli interessi (il saldo primario) sono in pareggio, allora grazie alle minori entrate, vanno in passivo, cioè si forma un disavanzo primario. Poiché il disavanzo, se non è finanziato con moneta cartacea2, è finanziato con l’emissione di obbligazioni del debito pubblico, ecco che negli anni successivi occorrerà considerare la spesa per interessi: il debito pubblico cresce anche per effetto dell’onere da interessi3.
L’altro elemento da considerare è il tasso di crescita del PIL, se l’economia nazionale cresce le entrate fiscali migliorano. E se le spese non aumentano allora una parte dell’avanzo primario servirà per rimborsare i titoli del debito pubblico in scadenza e l’anno successivo il debito sarà inferiore. In Italia la crescita economica (il PIL) dal 2009 è molto bassa4 e ciò ha portato ad un incremento del rapporto debito/PIL il quale alla fine del 2010 risulta essere pari al 118,4%: il livello più alto d’Europa dopo la Grecia, ma con un valore assoluto molto più elevato, lontano dal 2° parametro di Maastrich che fissa il livello del debito pari al 60% del PIL.
Una politica di rientro del debito pubblico è cruciale in quanto l’Italia, nonostante presenti un deficit di bilancio tra i più contenuti della UE, appare tra le più esposte alla speculazione finanziaria anche rispetto ad una economia come il Giappone che presenta una rapporto debito pubblico/PIL intorno al 200%.5 Tutto ciò pone il c.d. problema della “sostenibilità del debito pubblico”. Secondo i principi enunciati dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) un debito pubblico è sostenibile se soddisfa la seguente condizione: se il valore attuale degli avanzi primari attesi è uguale allo stock del debito. Ma non esiste alcuna linea direttrice certa per la valutazione della sostenibilità del debito pubblico; anzi a volte è sufficiente la credibilità che i mercati finanziari hanno nelle istituzioni e nelle scelte di politica economica adottate dai governi. Indubbiamente una politica di bilancio rigorosa incentrata sull'effetto combinato di un avanzo primario positivo e di una minore spesa per interessi porta ad una riduzione del debito pubblico sempre più veloce, sempreché parte del risparmio derivante dalla minor spesa per interessi non venga utilizzata per altre spese, in tal caso la discesa del debito sarebbe più lenta6. Ovviamente una siffatta strategia di bilancio deve essere accompagnata da una ripresa dell’attività produttiva che porta ad un aumento delle entrate erariali.
Nel grafico e nella tabella successivi si mostra l’andamento del debito pubblico italiano negli ultimi anni; si può notare che da dal 1999 vi è un andamento ad U, in particolare nel periodo 1999 fino al 2007 il rapporto presenta una traiettoria discendente per poi invertire la tendenza.

*****************
[1] Un documento ufficiale del 2010 della Commissione europea recepisce un accordo politico tra governi e prevede che un livello del rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60% sia accettabile se esso si è ridotto nei tre anni precedenti ad un tasso annuo medio dell’ordine del 5%. E’ vero anche che le regole di Maastrich e la loro evoluzione nel Patto di stabilità e crescita, sembrano avere una applicazione differente a seconda di chi le violi, ovvero, in passato la Commissione europea non ha mai applicato sanzioni nei confronti di quei Paesi membri che presentavano “disavanzi eccessivi”.
[2] La pratica del ricorso alla emissione di nuova moneta legale per finanziare gli scoperti di bilancio è da considerarsi un mezzo eccezionale per i suoi noti effetti inflazionistici.
[3] L’incremento di punti percentuali dei tassi di interesse si traduce in miliardi di euro che lo Stato deve pagare in più all’anno. Ciò costringe lo Stato necessariamente ad indebitarsi ulteriormente per poter fronteggiare i maggiori oneri. Per questo si afferma che il volume del debito pubblico influenza l’onere del debito, ma questo, a sua volta determina un “effetto ampliativo sul volume del debito”.
[4] Anche se fino al terzo trimestre dell’anno 2011 l’Italia ha avuto bassi tassi di interesse per la remunerazione del debito pubblico, tutto ciò è stato vanificato da una crescita economica molto limitata: secondo il rapporto ISTAT nel decennio 2001-2010 l’Italia ha realizzato la performance di crescita peggiore tra tutti i paesi dell’Unione europea con un tasso medio annuo di appena lo 0,2 per cento contro l’1,3 registrato dall’Ue e l’1,1 dell’Uem.
[5] Il Giappone è meno esposto alle turbolenze finanziarie e alla conseguente variazione dei tassi verso l’alto perché, a differenza dell’Italia, in larga parte il debito pubblico è detenuto da investitori domestici. Infatti l’immutata propensione degli investitori e la loro preferenza per i titoli di Stato nipponici concorrono ad assicurare al paese un finanziamento del debito e dei tassi di interesse bassi e assai inferiori a quelli pagati dall’Italia.
[6] L’altra faccia della medaglia è che una politica di soli tagli limita fortemente l’utilizzo di risorse per rilanciare la politica industriale del Paese e per rafforzare gli strumenti del Welfare.
di Ivan Lombardi [Visita la sua tesi »]
Articolo Esterno
-
L'Autore
Ivan Lombardi è nato a Benevento il 5 marzo 1971 ed è laureato in Economia e Commercio – indirizzo bancario - presso l’Università degli Studi del Sannio con la tesi Il polo conciario di Solofra come Distretto Industriale. Ha frequentato il Master di Primo Livello in Discipline giuridiche-economico-aziendali “E-COMMERCE” organizzato dall’Università degli Studi di Camerino, terminato con la tesi Il...»
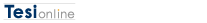
 Iscriviti alla Newsletter Economia!
Iscriviti alla Newsletter Economia!
La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: [email protected] o via Skype