Gap Inflazionistico secondo Keynes

Nel novembre del 1939 John Maynard Keynes scrisse una serie di articoli per il quotidiano inglese,The Times, sul tema della finanza di guerra, che, una volta modificati ed estesi, formò il supporto teorico del famoso saggio How to Pay for the War, (1940), (Come pagare il costo della guerra).
In questo lavoro, l’autore affronta, in maniera specifica, la stretta relazione che, in una situazione di pieno impiego delle risorse, intercorre tra il problema dell’eccesso della domanda globale e il fenomeno inflazionistico. Quest’opera, scritta in piena guerra, enuclea, infatti, uno stato d’inflazione che presenta caratteristiche peculiari; in particolare, Keynes definisce uno squilibrio inflattivo che, al termine del conflitto mondiale e con un apparato produttivo non ancora riconvertito alle esigenze normali della domanda civile, riversa sul mercato una smisurata quantità monetaria rispetto alle potenziali capacità di espansione dell’offerta reale ancora sostanzialmente rigida.
Il punto centrale, discusso da Keynes, consiste nell’accordare la possibilità al governo di attingere dalle mani dei privati consistenti risorse reali, necessarie per il finanziamento del conflitto e, al tempo stesso, di ridurre al minimo, in termini di contrasti sociali e di instabilità del circuito monetario, i costi generati da una simile operazione. Nel quadro di un sistema di economia di guerra, in particolare, se la quota destinata all’acquisto di beni di consumo e d’investimento da parte degli operatori economici privati (ossia famiglie ed imprese), sommata alla spesa sostenuta dall’amministrazione pubblica risulti superiore a quella compatibile con il prodotto nazionale, allora, si creerà un divario, che viene definito gap inflazionistico.
L’essenza del discorso keynesiano sul problema del vuoto inflazionistico si può rappresentare graficamente attraverso il familiare diagramma definito “a croce keynesiana”.
Se riportiamo la spesa reale globale (E) lungo l’asse delle ordinate e il reddito reale (X), invece, lungo l’asse della ascisse, in conformità con la tradizionale tassonomia keynesiana la spesa reale progettata può essere divisa in consumi C, in investimenti I, e infine in spesa pubblica G. Pertanto, la funzione della spesa globale, C+I+G, mette in relazione il livello della spesa reale producibile con il livello del reddito reale. L’intersezione della curva della spesa totale con la bisettrice (in corrispondenza della quale i valori delle ascisse, cioè il reddito, e i punti delle ordinate, ossia la spesa, si equivalgono) individua il livello di equilibrio del reddito nazionale reale Xe. In sostanza, quando il reddito nazionale è pari a Xe., l’ammontare complessivo di beni e servizi prodotti nel sistema è uguale alla spesa globale desiderata in termini reali.
Ma supponiamo, per un istante, che Xe. sia un livello di reddito inattuabile e che, ad esempio, sia Xg il livello di reddito di piena occupazione ottenibile in assoluto dalle risorse; esso rappresenta altresì il limite massimo oltre il quale non può andare la produzione. Il fatto che Xe. sia maggiore di Xg implicherà che la spesa reale ex post non riuscirà a raggiungere il suo valore ex ante. Di conseguenza, si verificherà una pressione verso l’alto sui prezzi e si potrà affermare che esiste un gap inflazionistico pari al tratto di segmento AB. In altre parole, ciò significa che, in corrispondenza del reddito di pieno impiego, si ha un vuoto inflazionistico, ovvero un eccesso di spesa globale reale ex ante rispetto al reddito reale producibile incolmabile con un aumento della produzione.

Il settore, che nel sistema economico si presenta immediatamente più esposto all’apertura di questo eccesso di domanda, è il mercato dei beni di consumo. In effetti, lo scenario di un evento bellico determina non solo il raggiungimento dell’obiettivo di piena occupazione della manodopera e, quindi, tramite un aumento del monte salari, una maggiore richiesta di tali beni, ma anche uno spostamento delle risorse tecniche verso gli impieghi bellici.
In un simile contesto storico, la proposta, suggerita da Keynes, si fonda, essenzialmente, sull’idea di differire nel tempo il volume dei consumi correnti, grazie all’intervento di un programma di salari ritardati, da finanziare alla fine del conflitto mediante un’imposta straordinaria sul capitale.
Per comprendere la validità oggettiva del suo ragionamento, è interessante riportare l’esempio numerico che Keynes approfondisce nel suo saggio.
Nell’ipotesi di un’economia di guerra sia:
X, il livello del prodotto reale (misurato, come tutte le variabili che seguiranno, a prezzi anteguerra) pari a £5.500ml2
E, il reddito privato di £6.000ml.
T, il gettito delle imposte di £1.400ml.
Ne consegue che Ed, il reddito personale disponibile (E-T) sarà uguale all’importo di 4.600ml.
Nell’ambito del suo modello, Keynes suppone, inoltre, che l’amministrazione pubblica, G, (compresi anche gli investitori privati) sia in una posizione, tale da acquistare 2250ml in beni e servizi necessari per l’efficace conduzione dello sforzo bellico, al livello dei prezzi prevalenti prima dell’esplosione inflazionistica.
La porzione di reddito nazionale, che rimane disponibile nelle mani della collettività, è data dalla seguente differenza:
X-G = 5.500 – 2.250 = £3.250ml
Il reddito reale di 4.600ml dei privati si confronta, quindi, con un’offerta di beni e servizi destinati per l’eventuale consumo personale, pari ad un valore di soli 3.250ml.
Per determinare l’estensione del gap inflazionistico, a questo punto, è opportuno considerare la formazione del risparmio privato; nell’esempio di Keynes, il pubblico risparmia volontariamente 700ml, e, la domanda aggregata effettiva, di conseguenza, ammonterà a 3.900ml Il gap inflazionistico, che indica l’eccedenza di spesa globale ex ante rispetto al reddito reale producibile, è, dunque, di 650ml, (3.900 – 3.250), e:
“ovviamente i prezzi dovranno salire nella misura del 20%, a cui l’offerta eguaglierà la domanda: i beni, infatti, avranno allora un valore di 3900 (3250 + 650) milioni di sterline, eguale appunto alla somma che il pubblico desidera spendere”.
Il prodotto reale nazionale, inoltre, che valeva £3250ml a prezzi anteguerra, viene ora venduto a prezzi correnti accresciuti per un ammontare complessivo di £ 3900 ml, provocando un’eccedenza di £ 650ml; in altre parole, una ventata di profitti inaspettati ed eccezionali conseguiti dalle aziende. In questo modo avremo:
“redditi potenzialmente spendibili per £ 5250 (4600 + 650) milioni di sterline, a fronte di beni che, tenendo conto del perdurante aumento dei prezzi del 20% hanno un valore di soli milioni di sterline”.
Questa vicenda innescherà necessariamente un nuovo eccesso di domanda sul mercato dei beni di consumo, con immediati risvolti inflattivi, in quanto assisteremo:
“ad una sostanziale divaricazione tra l’ammontare di moneta che il pubblico è pronto a spendere e il valore (al nuovo livello dei prezzi, superiore del 20% a quello precedente) dei beni disponibili per l’acquisto. Si renderà quindi un ulteriore aumento dei prezzi, che consentirà una tregua temporanea, e così via”.
Secondo la riflessione teorica keynesiana, pertanto, il meccanismo precipuo per chiudere il divario inflazionistico non risiede nell’incremento progressivo del livello generale dei prezzi, giacché una loro fluttuazione implicherà un aumento dei redditi monetari, e conseguentemente una regolare ricostituzione del potere d’acquisto degli operatori economici. Al fine di evitare che la spirale del processo inflazionistico diventi incontrollabile, l’autore suggerisce, allora, che le forze correttive debbano essere ricercate in altre direzioni.
Innanzitutto, come messo in evidenza dallo stesso Keynes, s’intuisce l’idea che nel momento in cui i prezzi incominciano a salire:
“non tutti i singoli redditi cresceranno nella stessa proporzione, ed anzi alcuni non aumenteranno affatto. L’incremento iniziale dei redditi riguarderà principalmente una ristretta classe d’individui e di società commerciali e industriali, che possiamo, per brevità, chiamare i profittatori. Ora, questi profittatori sono soggetti ad un’aliquota d’imposta molto elevata, sia in seguito all’imposta sui profitti supplementari, sia perché molti di loro saranno abbastanza ricchi per essere soggetti a forti aliquote d’imposta e di sovrimposta sul reddito […]”.
In questo modo, secondo l’opinione di Keynes, dal 50 al 75% della crescita iniziale dei prezzi al consumo dovrebbe essere assorbito dallo Stato, attraverso l’applicazione di un sistema di imposte nei confronti degli stessi imprenditori, la cui incidenza progressiva avrà ripercussioni negative anche sulle decisioni d’investimento degli operatori.
Successivamente, proseguendo il suo discorso sul comportamento dei cosiddetti “profittatori”, afferma che:
“[…] è possibile che una parte considerevole di questa eccedenza sia risparmiata volontariamente; e ciò non tanto perché coloro che la percepiscono, essendo già relativamente ricchi, siano più propensi a risparmiare, ma piuttosto perché i profitti in questione apparterranno, in larga misura, a società che, per varie ragioni, saranno poco inclini a distribuirne la gran massa sotto forma di dividendi più alti, ma preferiranno invece, date le circostanze, risparmiarli per conto dei propri azionisti”.
In questa guisa, l’incremento del reddito monetario che dovrebbe trasformarsi in un ennesimo rialzo della domanda aggregata nel mercato dei beni al consumo nella seconda fase del processo inflattivo verrebbe ad essere ulteriormente ridotto. A tale riguardo, infatti, Keynes conclude che:
“[…] invece di rendersi necessario un ulteriore aumento dei prezzi del 20%, potrebbe bastare, per mantenere l’equilibrio, un aumento del 2% o del 3%. In tal caso, un lieve inasprimento dell’imposizione fiscale nei confronti della collettività, in genere, sarà sufficiente a controbilanciare l’accresciuto consumo dei profittatori e a far venir meno la necessità […] di ulteriori innalzamenti dei prezzi oltre quello iniziale del 20%”.
Fino a questo punto, il metodo d’indagine condotto da Keynes fornisce, tuttavia, un quadro incompleto delle relazioni economiche, dal momento che si fonda sulla rigida supposizione che la categoria dei lavoratori adotti un atteggiamento compiacente, nel senso che essa assiste debolmente all’erosione del suo salario reale, conseguente ad un’inflazione dei prezzi dei prodotti finali. In realtà, questo fatto si configura come un’ipotesi estrema, perfino, in tempo di guerra. In una situazione di eccesso di domanda di lavoro risultante dall’apertura dello scarto inflazionistico, i percettori di profitto possono avvalersi della favorevole occasione di utilizzare una parte dei loro guadagni inattesi, al fine di finanziare un incremento delle paghe dei dipendenti, invece di consentire che una loro fetta di introiti venga pesantemente tassata. In questa direzione, si esprime efficacemente l’illustre economista, quando scrive che:
“nella realtà, i lavoratori premeranno per avere salari più alti, ottenendo un successo almeno parziale. I datori di lavoro, infatti, opporranno ad un aumento salariale una resistenza molto minore del solito: da un lato, la scarsità di manodopera li costringerà a cedere, se non intendono perdere i propri dipendenti; e, dall’altro, poiché il governo si porta via sotto forma di imposte il 75% dei loro profitti supplementari, non sarà per essi un grande sacrificio spartire tali profitti con il loro personale salariato e stipendiato”.
Seguendo fedelmente le linee di questo ragionamento, tuttavia, avremo un modello di inflazione, nel quale i prezzi rispondono alle tensioni della domanda sul mercato dei beni al consumo e i salari nominali mutano conseguentemente, il cui risultato finale non sarò altro che la realizzazione di una pericolosa spirale prezzi-salari.
Nel tentativo di smorzare il grado d’intensità del fenomeno inflazionistico, diventa, allora, punto focale, per l’analisi di Keynes, l’assunzione dell’ipotesi convenzionale di ritardo dell’adeguamento salariale; in pratica, la retribuzione si aggiusta rispetto al cambiamento del livello generale dei prezzi, solo dopo che trascorra, inevitabilmente, un certo lasso di tempo. Le maggiorazioni di prezzo, infatti, corrono sempre in testa alle esplosioni salariali, che li seguono con uno sfasamento temporale ben preciso e programmato, cosicché i salari reali siano costantemente più bassi, sotto il livello che avevano prima dell’inizio dell’evento inflattivo. In sintesi, quanto più breve sarà la distanza tra gli aumenti salariali e il precedente incremento dei prezzi, tanto più alto sarà il saggio d’inflazione. Per quanto attiene l’ultimo concetto, Keynes è estremamente chiaro:
“i salari e gli altri costi saliranno, inseguendo i prezzi, ma, ciò nondimeno, i prezzi […] saranno sempre più alti del 20%: per quanto i salari siano aumentati, la spendita di essi spingerà sempre in alto i prezzi in questa stessa misura. Se, in effetti, i salari e gli altri costi monetari dovessero salire in misura pienamente proporzionale al costo della vita, ci troveremmo di fronte, ad un’inflazione senza limiti, che progredisce del 20% ad ogni stadio, quel processo generalmente noto come spirale viziosa”.
La risposta ritardata dei salari ai movimenti dei prezzi, su cui Keynes pose una notevole enfasi, sebbene ristabilisca l’equilibrio auspicato tra reddito e consumo, produce, però, un risultato sorprendente; la persistenza dell’inflazione costituisce lo strumento attraverso il quale lo scarto inflazionistico viene eliminato. In altri termini, è il ritmo del processo inflattivo, che evita il sorgere dell’eccedenza iniziale di spesa ex ante sul prodotto reale nazionale. Il freno dell’adeguamento retributivo ai prezzi, infatti, ci assicura che il salario reale diminuirà e che la porzione dei percettori di profitto al lordo delle imposte aumenterà, originando l’effetto voluto, ossia una complessiva riduzione del consumo attuale ed un concomitante potenziamento dei risparmi.
A questo proposito, Keynes dice:
“così, dopo tutto, il sistema del risparmio volontario avrà funzionato con successo, nel senso che la quantità di moneta sarà stata aumentata volontariamente, senza un incremento illimitato dei prezzi. La sola condizione di tale successo è che i prezzi debbono salire, in rapporto ai salari, nella misura necessaria a convogliare l’opportuno ammontare di redditi della classe lavoratrice e di altri gruppi nelle mani dei profittatori e, da queste, nelle casse del Tesoro, principalmente sotto forma di imposte e, in parte, sotto forma di risparmio volontario supplementare da parte dei profittatori” .
Da quest’ultima affermazione, si ricava, quindi, l’idea che il sistema di distribuzione del reddito nazionale assume un’importanza decisiva nella formulazione dello schema del gap inflazionistico, descritto nell’opera di Keynes. L’andamento dell’inflazione consente, in sostanza, di trasferire il reddito dalla categoria dei salariati a forte consumo, ossia coloro che hanno una bassa propensione al risparmio e che sono tassate con contenute aliquote fiscali, a favore dell’altra classe sociale degli imprenditori, che presentano, invece, un’elevata inclinazione al risparmio e un carico di imposte assai gravoso. Infatti, il gap inflazionistico può essere chiuso da una ridistribuzione del reddito nazionale, che danneggi quelle classi sociali (i lavoratori) che risparmiano poco e sono soggette ad una imposizione fiscale mite, a favore di quei gruppi che risparmiano molto e che sono tassate pesantemente.
Il divario inflazionistico, insomma, è finanziato dal medesimo processo inflattivo, in cui l’ammontare dei salari reali è tenuto basso rispetto al cambiamento del livello dei prezzi, solo mediante un certo aggiustamento dilazionato.
[Nell'immagine: John Maynard Keynes sulla copertina del TIME]
di Nicola Simonetti [Visita la sua tesi »] [Leggi i suoi articoli »]
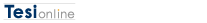
 Iscriviti alla Newsletter Economia!
Iscriviti alla Newsletter Economia!
La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: [email protected] o via Skype