La Tobin Tax, tra utopia e opportunità
Imposta sulle transazioni finanziarie in valuta
In momenti in cui la finanza sembra non rispondere più alle esigenze di risparmio e investimento dell’economia reale, si fanno più insistenti le richieste di una tassazione che vada a colpire gli speculatori e aiuti a ristabilire equilibrio nei mercati.
La Tobin tax, presentata per la prima volta nel 1971 dal professor e premio Nobel James Tobin, è stata per anni oggetto di dibattito nell’opinione pubblica ma non è mai veramente entrata nell’agenda dei governi avanzati per mancanza volontà politica e per il timore di scoraggiare gli investimenti o ledere gli interessi degli intermediari finanziari.
Ma di cosa si tratta? Nient’altro che un’imposta dello 0,5 o dell’1% da applicare ad ogni transazione finanziaria sul mercato dei cambi.
Spesso frettolosamente bollata come utopistica o non realizzabile, ritrova invece periodicamente interesse in alcuni economisti e nella società civile nei momenti di crisi di mercato. Succede quindi oggi come successe nella crisi dello SME nel 1992-93 o dopo il crollo del peso messicano del 1994 quando anche Mitterrand se ne fece promotore. Negli anni ’90 anche il Fondo Monetario Internazionale ha riconosciuto che sarebbe stato necessario trovare misure necessarie a frenare il flusso instabile di capitali a breve termine. Spesso, l’espressione che viene usata risale ad una stessa metafora pensata da Tobin:“gettare un po’ di sabbia nei troppo ben oliati ingranaggi del mercato”.
E’ lo stesso Tobin a sottolineare che i cosiddetti chartists o noise traders, in italiano comune “speculatori”, hanno orizzonti temporali molto brevi per gli investimenti effettuati e un’imposta sulle transazioni scoraggerebbe loro molto di più di quanto non deprimerebbe gli investimenti guidati da operatori che basano le proprie previsioni sui fondamentali di lungo periodo o su previsioni estrapolative.
Per così direi, la Tobin tax cambierebbe il “prezzo relativo” degli strumenti finanziari andando a rendere più costosi e meno appetibili gli investimenti esteri di breve termine. Un investimento di capitali a lungo termine, con una durata tra i 12 mesi e i 5 anni, richiederebbe un tasso di interesse di poco superiore a quello interno per stimolare l’investimento. D’altra parte invece, per investimenti di breve termine, quando cioè l’investitore ha in mente un orizzonte temporale inferiore ai 3 giorni, sarebbero necessari tassi di rendimento esterni molto molto maggiori rispetto a quelli ottenibili sul mercato intermo. L’imposta è sì applicata su tutte le tipologie di transazione, ma penalizza le transazioni speculative di breve periodo, limitando la distorsione degli investimenti di medio e lungo periodo.
E’ interessante notare che secondo dati della Bank for International Settlements (BIS), a livello mondiale, circa l’80% delle transazioni sul mercato dei cambi consistono in movimenti circolari che si risolvono entro una settimana. Circa il 40% invece si risolve entro le 48 ore.
Chi propone l’adozione della tobin tax sottolinea che la sua introduzione potrebbe avere tre risultati principali:
1. La riduzione della volatilità del tasso di cambio.
2. L’aumento della libertà d’azione dei governi e delle banche centrali riguardo
le politiche fiscali e monetarie.
3. Il conseguimento di un notevole gettito per sanare le finanze pubbliche
Tra gli economisti, le voci contrarie all’introduzione di una tassazione del genere certo non mancano. In particolare, coloro che credono nell’efficienza del mercato e nella razionalità delle aspettative sostengono che una simile imposta ostacolerebbe l’efficienza del mercato e diminuirebbe la liquidità disponibile. Secondo gli economisti contrari all’introduzione di una tassa sulle transazioni in valuta, per ridurre la volatilità del tasso di cambio si dovrebbe invece pensare di ridurre la variabilità delle politiche monetarie e fiscali.
E’ senza dubbio vero che un’imposta da applicare ad ogni transazione dovrebbe tentare di essere il meno distorsiva possibile.
Ad oggi, una tassazione per transazione pari all’1% così come fu inizialmente proposta da Tobin è sostanzialmente impensabile. Uno studio di Felix e Sau nel 1996, portò alla definizione un’aliquota dello 0,25% che doveva essere capace al contempo di garantire libertà d’azione alle banche centrali e contrastare la volatilità senza distorcere troppo il mercato. Recentemente, le organizzazioni internazionali e gli economisti, sono convenuti su un’aliquota ancora più minimale. Si parla infatti di uno 0,05% o al massimo di uno 0,1%. In questo modo, le distorsioni sul mercato dei cambi sarebbero realmente minime, ma contando su un enorme numero di transazioni, il gettito ricavato sarebbe comunque ingente.
E come scrive Andrea Chiari, “le principali problematiche dell’imposta non sono tanto la sua difficoltà di implementazione o i possibili mezzi che potrebbero essere usati per evaderla, ma il fatto che essa si pone in controtendenza al processo di globalizzazione e di completa liberalizzazione dei capitali, che costituisce il “credo” dei grandi centri del potere economico.”
di David Rinaldi [Leggi i suoi articoli »]
Tesi Correlate
-
L’imposta Tobin: nuove prospettive
Andrea Chiersi fornisce un’ottima introduzione all’argomento presentando obiettivi e critiche alla proposta di Tobin. Per comprendere al meglio l’utilità di una tassazione sulle transazioni del mercato dei cambi, viene anche presentata la struttura del mercato con un’attenta analisi delle principali fonti di instabilità.
La tesi, facendo riferimento al lavoro di Dornbush e Frankel (1988) fornisce...» -
La Tassazione alla Tobin delle Transazioni in Valuta
Si tratta di un lavero veramente approfondito, che analizza l’applicazione della Tobin tax da ogni punto di vista.
Pellizzato evidenzia come tra le critiche che sono state mosse contro la Tobin tax vi sia chi critica gli effetti dell'imposizione e chi è invece scettico sulla possibilità di una sua reale introduzione. Il focus primario rimane quello di procedere ad un serio studio di fattibilità che...»
Approfondimenti
-
La Tobin Tax, tra utopia e opportunità
Spesso frettolosamente bollata come utopistica o non realizzabile, ritrova invece periodicamente interesse in alcuni economisti e nella società civile nei momenti di crisi di mercato. L'articolo introduce alla Tobin tax e fornisce una visione sui pro e su i contro. Sono infine presentati contributi tecnici che analizzano la fattibilità e i modelli di teoria economica.»
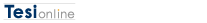
 Iscriviti alla Newsletter Economia!
Iscriviti alla Newsletter Economia!
La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: [email protected] o via Skype