PIL e qualità della vita

Lo stimolo alla redazione del presente articolo mi è stato fornito dalla lettura del libro saggio di Jeremy Rifkin, recentemente uscito, “Il sogno europeo”.
La dizione Prodotto Interno Lordo o comunemente PIL è universalmente e pacificamente accettata come la misura fondamentale della ricchezza di un paese e la quota pro capite del PIL che si ottiene dividendo il suo ammontare complessivo per il numero di abitanti viene generalmente accreditata essere un indicatore del grado del benessere dei cittadini. Se un paese ha un PIL elevato e se il suo tasso di crescita da un anno all’altro è significativo, per l’immaginario collettivo (ma anche per molti governanti ed economisti) esso è un paese ricco e si ritiene che i suoi cittadini siano benestanti. Ma è proprio così? Non è fuor di luogo ripercorrere il cammino storico che ha condotto all’“invenzione” del PIL e della sua successiva generalizzata adozione da parte di tutti i paesi del mondo.
Nei primi anni ’30, in seguito a quella che è stata chiamata la Grande Depressione, i politici di Washington erano pienamente consapevoli che le cose andavano male, ma non potevano sapere “quanto male” perché non avevano informazioni sull’economia, né sufficienti né attendibili. I dati a loro disposizione erano pochi: quelli relativi alla produzione di acciaio, alle quotazioni di borsa, ai pronunciamenti di Henry Ford e a dati parziali sull’occupazione: francamente un po’ poco. Tutto ciò doveva cambiare nel 1933 allorché un piccolo staff di ricercatori governativi presso Ministero del Commercio, guidati da un economista di nome Simon Kusnets, di origine ucraina, mise a punto la formula del Gross National Product, che sarebbe diventata il prototipo di quello che noi chiamiamo PIL, e che tutti gli studenti di economia conoscono. Da allora il governo americano, e via via altri governi, hanno assunto questa misura come un riferimento ufficiale per l’attuazione della politica economica. Si tratta di una formula tanto semplice (Y = C+I+G +X ovvero Produzione totale = Consumi + Investimenti + Spesa pubblica + Esportazioni nette) da apparire disarmante tantè che dei suoi limiti, lo stesso Kusnets, si sentì in dovere di mettere in guardia il Senato americano, in un suo intervento del 1934, con le seguenti parole: (“The welfare of a nation can scarcely be inferred from a measurement of national income as defined above”. “Il benessere di una nazione può essere difficilmente rappresentato da una misura di produzione nazionale come quella suesposta”). Le riserve di Kusnets sulla bontà della misura del PIL avrebbero portato lo stesso economista a rompere il suo rapporto con il Ministero del Commercio, negli anni ‘40, quando questo non volle ammettere l’apporto del lavoro domestico come un’importante componente del PIL stesso. Nonostante ulteriori riserve e perplessità espresse da studiosi ed economisti nel corso del tempo, la nozione di PIL è fino ad oggi rimasta intaccata da sembrare uno scontato proclama inattaccabile, unico e vero metro dello stato di benessere dei paesi e dei suoi cittadini. Basti pensare ai sacrifici compiuti dall’Italia con riferimento al PIL per entrare a far parte del club dell’euro.
Nel 1995 tre economisti Cobb, Halstead e Rowe hanno scritto un lungo ed esaustivo articolo per The Atlantic Magazine dal significativo titolo If the GDP is Up, Why America is Down? (“Se il prodotto interno lordo è su, perché l’America è giù?” Nota: dal 1973 al 1995 il PIL americano era cresciuto, in termini reali, del 55% mentre i salari reali erano diminuiti del 14%) sui problemi del PIL con una critica puntuale ed esauriente che si può sintetizzare in tre punti:
1. Il PIL tiene conto di tutte le transazioni in denaro e trascura tutte quelle a titolo gratuito, restano quindi escluse le prestazioni nell’ambito familiare e quelle attuate dal volontariato (si pensi al valore economico del no profit).
2. Il PIL tratta tutte le transazioni come positive, cosicché ne entrano a far parte i danni provocati dai crimini, dall’inquinamento, dalle catastrofi naturali. (Esempio: se compri un auto il PIL cresce, se hai un incidente, il PIL cresce, se sei ospedalizzato il Pil cresce e così via). In questo modo il PIL non fa distinzione tra attività che contribuiscono al benessere da quelle che lo diminuiscono, è come fare la contabilità con la calcolatrice che ha il segno più ma non ha il segno meno.
3. Il PIL tratta il deprezzamento del capitale naturale ed ambientale come componente positiva e ciò rappresenta una violazione dei sani principi contabili. Facciamo un esempio. Se una proprietà agricola di pregio viene trasformata in un parcheggio, il PIL contabilizza l’ammontare del denaro coinvolto ma non considera il deprezzamento del capitale naturale per una siffatta trasformazione (da suolo fertile e produttivo a superficie asfaltata).
Gli autori succitati propongono un diverso indicatore economico che prevede anche componenti sottrattive, chiamato Genuine Progressive Indicator o GPI. Ma questo potrà essere oggetto di un altro articolo.
Ritornando al titolo, da quanto esposto, viene messa fortemente in dubbio la correlazione tra qualità della vita e PIL. Innanzitutto la quota di PIL pro capite non può provare la diffusione del benessere tra i cittadini: ciò evidentemente dipende dalla ridistribuzione della ricchezza e ciò il PIL non lo può dire. Al contrario, il PIL pro capite può ingenerare una visione distorta del benessere soggettivo nella misura in cui la ricchezza è inegualmente distribuita e i redditi individuali mostrino delle forti disparità. Qui accettiamo il fatto che un maggiore reddito per le famiglie si ripercuota nella qualità della vita perché, permettendo spese aggiuntive, può soddisfare delle aspettative materiali legittime.
Ma le nuove concezioni di benessere-qualità della vita comprendono, a ragione, molte componenti immateriali che sono di difficile se non di impossibile rappresentazione in un sistema di conti. Per esigenze di sintesi citiamo fra gli indicatori oggettivi di qualità della vita i seguenti (su cui ragionevolmente ci può essere condivisione):
- stato di salute
- speranza di vita in buona salute
- condizioni lavorative
- stato delle relazioni sociali
- qualità dell’ambiente
Facciamo qualche esempio con riferimento alle condizioni lavorative. Se il mio nuovo posto di lavoro è salubre, è piacevole, è sicuro e l’ambiente umano è impostato alla correttezza e allo spirito di collaborazione io aggiungo qualità alla mia vita e così pure se per raggiungere il luogo di lavoro ho una distanza di percorrenza breve con un servizio pubblico efficiente in termini di puntualità e gradevole in termini di confort e ancora, se il mio rapporto prevede un orario flessibile.
Altro esempio. Siamo una coppia, abbiamo un figlio piccolo ed entrambi lavoriamo. Se abbiamo la scuola materna nelle vicinanze abbiamo un servizio che influenza positivamente la nostra routine quotidiana.
Come si può evincere, se si riflette sugli aspetti immateriali, solidali e sociali del vivere, la relazione tra PIL e qualità della vita si fa sempre più esile ed è perciò che mentre da una parte il PIL deve sussistere come indicatore del quadro macroeconomico e come valido come strumento di confronto tra le economie dei diversi paesi , dall’altro, sul versante della vita del cittadino non deve essere eretto ad indicatore obiettivo del benessere del singolo né tanto meno della sua felicità. In realtà l’unico misuratore del benessere materiale dell’individuo potrebbe essere il suo reddito personale contrapposto al costo della vita che lui conduce ossia a quanto egli ritiene di potere acquistare per placare i bisogni che lui ritiene essenziali per sé. Non si illuda lo spettatore che segue il TG Economia che all’annuncio della crescita del PIL un virtuoso automatismo gli porti un diretto beneficio personale e altrettanto non si demoralizzi eccessivamente se l’andamento del PIL non sia quello sperato.
di Pierpaolo De Nardi [Visita la sua tesi »] [Leggi i suoi articoli »]
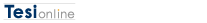
 Iscriviti alla Newsletter Economia!
Iscriviti alla Newsletter Economia!
La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: [email protected] o via Skype